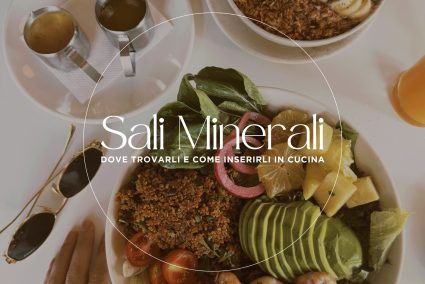C’è chi da bambino mangiava volentieri verdure, legumi e piatti “da grandi”, e chi invece ha passato l’infanzia a scansare tutto ciò che non fosse pasta in bianco o patatine. Crescendo, queste differenze spesso rimangono: alcuni adulti amano sapori intensi come il caffè amaro o il radicchio, altri continuano a evitarli con convinzione. Da qui nasce una domanda che incuriosisce genitori, educatori e chiunque ami il cibo: il gusto è qualcosa con cui nasciamo o qualcosa che impariamo?
La risposta non è netta, ma è proprio questo a renderla interessante. Il gusto è il risultato di un dialogo continuo tra biologia, esperienza, cultura e memoria. Un intreccio che comincia molto prima di quanto immaginiamo e che continua, silenziosamente, per tutta la vita.
Il gusto nasce prima di quanto pensiamo
Il nostro rapporto con il cibo inizia ben prima dello svezzamento. Durante la gravidanza, il feto è immerso nel liquido amniotico, una sostanza che non è affatto neutra: il suo sapore cambia in base a ciò che mangia la madre. È stato osservato che aromi di alimenti come aglio, carota, vaniglia, anice o spezie attraversano la placenta e arrivano al liquido amniotico, stimolando i recettori gustativi e olfattivi del feto.
Questo significa che il gusto inizia a essere “allenato” già nel grembo materno. Non parliamo di preferenze consapevoli, ovviamente, ma di una prima familiarità sensoriale. Studi condotti su neonati mostrano che bambini esposti in gravidanza a determinati aromi reagiscono in modo più positivo a quegli stessi sapori nei primi mesi di vita.
Dopo la nascita, l’allattamento al seno continua questo processo. Il latte materno cambia leggermente sapore a seconda della dieta della madre, offrendo al bambino un’esperienza gustativa varia e dinamica. È una sorta di ponte naturale tra il mondo intrauterino e il cibo vero e proprio.
La genetica conta, ma non decide tutto
La biologia ha il suo peso, ed è inutile negarlo. Esistono differenze genetiche che influenzano il modo in cui percepiamo i sapori. Uno degli esempi più noti riguarda la sensibilità all’amaro. Alcune persone possiedono varianti genetiche che rendono i recettori dell’amaro più reattivi: per loro certi vegetali, come broccoli, cavolfiori o cicoria, risultano particolarmente intensi e poco piacevoli.
Questo non significa che chi percepisce l’amaro più intensamente sia “difficile” o viziato: semplicemente, assaggia un mondo leggermente diverso. Allo stesso modo, esistono differenze nella percezione del dolce, del grasso o dell’acido.
Ma la genetica non è un copione già scritto. Piuttosto è una base di partenza. Anche una forte sensibilità a un gusto può essere modulata dall’esperienza. Con il tempo, il cervello impara a integrare sensazioni nuove, a rileggerle, a smussarle.
Il gusto si allena (esattamente come un muscolo)
Uno dei dati più solidi emersi dalla ricerca sul comportamento alimentare è che il gusto si impara attraverso l’esposizione ripetuta. Questo vale soprattutto per l’infanzia, ma non solo. Un bambino può rifiutare un alimento semplicemente perché non lo riconosce. Il cervello umano, soprattutto nei primi anni, tende a diffidare di ciò che è nuovo.
Assaggiare più volte lo stesso cibo, anche in piccole quantità, aumenta la probabilità che venga accettato. Spesso servono molte esposizioni prima che un sapore diventi familiare. Questo processo è naturale e non va forzato: la familiarità nasce dalla ripetizione, non dall’obbligo.
Anche le modalità di preparazione contano. Uno stesso alimento può risultare sgradito in una forma e piacevole in un’altra. Il gusto non è mai isolato: è sempre accompagnato da consistenze, profumi, colori e temperature.
Mangiare è anche un fatto emotivo
Il contesto in cui mangiamo ha un’influenza enorme sulla costruzione del gusto. Non impariamo solo cosa mangiare, ma come farlo. Un ambiente rilassato, senza pressioni, favorisce la curiosità. Al contrario, tensioni, forzature o ricatti emotivi possono creare associazioni negative difficili da superare.
Il cervello lega il sapore alle emozioni vissute in quel momento. Un piatto può diventare sgradito non per il suo gusto, ma per ciò che rappresenta. Per questo motivo, il piacere a tavola è una forma di educazione tanto quanto la varietà dei cibi.
Anche l’esempio conta: vedere gli adulti mangiare con gusto, senza commenti negativi, rende un alimento più accettabile. Il gusto si apprende anche per osservazione.
La cultura decide cosa è “buono”
Molte delle nostre preferenze non hanno nulla di biologico. Sono culturali. Ogni cucina tradizionale stabilisce confini invisibili tra ciò che è normale e ciò che è strano. Formaggi molto stagionati, pesce crudo, fermentazioni, spezie intense: ciò che in un Paese è quotidiano, in un altro può sembrare estremo.
Questo dimostra che il gusto è un linguaggio che impariamo all’interno di una cultura. Più l’esposizione è ampia, più il vocabolario gustativo si arricchisce. Non serve viaggiare lontano: basta una tavola curiosa, aperta, disposta a sperimentare.
Il gusto cambia anche da adulti
Una delle notizie più rassicuranti è che il gusto non si cristallizza mai del tutto. Anche in età adulta possiamo modificare le nostre preferenze. Cambiano le papille gustative, cambia il metabolismo, cambia il contesto sociale. Ma soprattutto cambia la nostra disponibilità mentale.
Molti alimenti che da bambini risultavano sgradevoli diventano accettabili o addirittura piacevoli con il tempo. Non per magia, ma per esposizione, maturità e nuove associazioni. Il gusto evolve lentamente, senza strappi, seguendo la nostra storia personale.
Allora, il gusto si eredita o si impara?
La risposta più corretta è che il gusto nasce dall’incontro tra ciò che siamo e ciò che viviamo. La genetica fornisce una predisposizione, l’ambiente costruisce il resto. Nessuno parte davvero da zero, ma nessuno è nemmeno prigioniero delle proprie papille.
Il gusto è memoria, esperienza, cultura, emozione. È una competenza che cresce con noi e che possiamo continuare ad allenare, un assaggio alla volta.