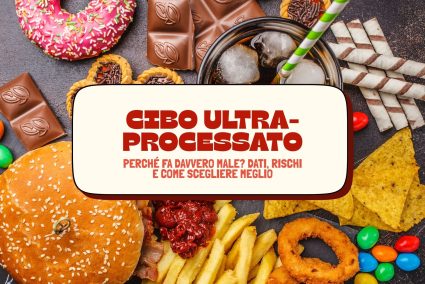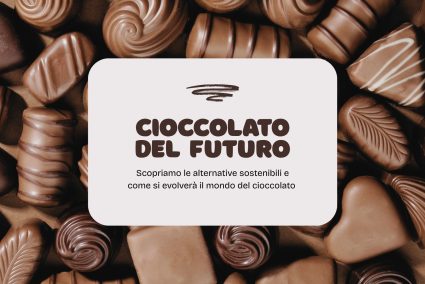Ogni volta che facciamo la spesa, ci capita di imbatterci in prodotti che sbandierano con orgoglio la scritta “senza conservanti”. È una formula che rassicura, che fa pensare subito a qualcosa di più naturale, più sano, quasi più “vero”. Ma la domanda da farsi è: siamo davvero sicuri che l’assenza di conservanti sia sempre un vantaggio? Per rispondere bisogna andare oltre lo slogan e capire prima di tutto cosa siano i conservanti, a cosa servano e in quali casi possano essere utili o dannosi.
Cosa sono i conservanti: definizione e funzioni
I conservanti sono sostanze, naturali o di sintesi, che hanno un compito preciso: rallentare il deterioramento degli alimenti. Possono agire bloccando la crescita di microrganismi come muffe, batteri o lieviti, oppure impedendo quei processi chimici che portano, ad esempio, i grassi a irrancidire o un frutto a scurirsi. In altre parole, sono dei piccoli “guardiani invisibili” che ci aiutano a mantenere il cibo commestibile più a lungo. Senza di loro, molti alimenti deperirebbero in tempi rapidissimi, e basterebbe una distrazione nel trasporto o nella conservazione per trovarsi con un prodotto alterato o addirittura pericoloso.
Si possono quindi dividere in due categorie principali:
-
Conservanti antimicrobici: contrastano direttamente la crescita di microrganismi (es: benzoati, sorbati, nitrati/nitriti).
-
Conservanti antiossidanti: contrastano i processi chimici dovuti all’ossigeno, che alterano colore, odore, sapore, e possono degradare vitamine o lipidi (es: BHA, BHT, acido ascorbico, acidi citrico e fosfati, etc.).
Perché si usano: i vantaggi concreti
Avere conservanti in un alimento porta diversi benefici reali:
-
Sicurezza – impedire la proliferazione di microrganismi pericolosi, come Clostridium botulinum, che possono produrre tossine molto pericolose. Ad esempio, i nitrati/nitriti usati nei salumi servono anche a prevenire il botulismo.
-
Riduzione dello spreco alimentare – se un prodotto si deteriora troppo in fretta, va buttato; conservanti ben regolati permettono di allungare la shelf life e ridurre gli scarti.
-
Conservazione delle caratteristiche organolettiche – gusto, aroma, colore, aspetto. Senza conservanti o con sistemi deboli, il prodotto potrebbe alterarsi più rapidamente, perdere sapore, diventare meno appetibile.
-
Supporto alle filiere lunghe e stagionalità – nei prodotti che attraversano grandi distanze o stagionalità, oppure nei cibi che devono resistere a condizioni di trasporto, conservanti permettono che l’alimento arrivi in condizioni accettabili al consumatore.
I rischi reali: cosa dice la scienza
Detto ciò, i conservanti non sono privi di potenziali effetti collaterali. Ecco cosa emerge da studi recenti:
-
Alcuni conservanti (ad esempio benzoati, nitriti/nitrati) sono associati, in determinate condizioni e dosaggi, con possibili rischi di sviluppo di composti dannosi o reazioni avverse. Per esempio, i nitriti possono dar luogo a nitrosammine, composti considerati potenzialmente cancerogeni.
-
Effetti su allergie o sensibilità: alcuni conservanti possono causare reazioni allergiche o scatenare asma, sebbene non in tutti. Ad esempio, i solfiti in soggetti sensibili possono provocare problemi respiratori.
-
Impatto sulla salute intestinale: c’è crescente evidenza che alcuni conservanti e altri additivi sintetici possano alterare la flora intestinale (microbiota), promuovere infiammazione intestinale o rendere la barriera intestinale meno robusta.
-
Rischi a lungo termine e dosaggi: molti studi segnalano che gli effetti indesiderati sono legati spesso a un consumo elevato, cronico, spesso attraverso cibi ultra-processati, piuttosto che l’uso moderato e tollerabile entro limiti stabiliti dagli enti regolatori.
Perché “senza conservanti” non è sempre sinonimo di migliore
Molti prodotti sfoggiano l’etichetta “senza conservanti” (o “senza conservanti artificiali”), e questo viene usato come leva di marketing. Ma l’assenza può avere implicazioni meno evidenti:
Sicurezza compromessa – un alimento che non ha conservanti può deteriorarsi più facilmente e rapidamente, favorendo sviluppo di muffe o batteri. Ciò può essere pericoloso, soprattutto se non sono rispettate condizioni di igiene e catena del freddo. L’assenza di conservanti richiede procedure produttive, confezionamenti e trasporti ancora più rigorosi.
Alternative che non sono sempre neutre – “naturale” non significa senza rischi. Conservanti naturali (sale, zucchero, acidi organici, estratti vegetali, fibre antimicrobiche naturali) possono avere limiti: gusto alterato, limitata efficacia, costi più alti, o anche reazioni in alcune persone.
Maggiore spreco alimentare – senza conservanti la durata del prodotto è più breve, il che può portare a ritirare prodotti, scartare alimenti invenduti, o che si deteriorano nel trasporto. Questo può avere un impatto economico, ambientale e anche sulla sicurezza se il prodotto deteriorato viene consumato.
Prezzo e accessibilità – prodotti “senza conservanti” spesso costano di più, sia per i metodi di conservazione alternativi, sia per gli impianti più sofisticati necessari. Questo può limitare l’accesso a cibi buoni e sicuri per fasce di popolazione con meno risorse.
Cosa dicono le normative e i limiti accettabili
-
In Europa (es. EFSA) e in Italia, così come in altri paesi, i conservanti sono regolamentati: ogni sostanza autorizzata ha un limite di utilizzo, un valore massimo consentito nelle diverse categorie di cibo, e viene valutata la sua tossicità, le possibili interazioni, gli effetti a lungo termine.
-
L’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) dà pareri scientifici basati su dati tossicologici, studi animali e, quando possibile, studi sull’uomo, per stabilire l’ADI (acceptable daily intake) cioè la dose giornaliera accettabile. Se il consumo rimane al di sotto dell’ADI, si considera che il rischio è basso.
-
Gli organismi regolatori monitorano inoltre l’uso reale nelle popolazioni, segnalazioni di effetti avversi, nuove ricerche, e possono revocare l’autorizzazione o ridurre i limiti se emergono rischi.
Come orientarsi per il consumatore curioso e attento
Se vuoi scegliere bene, evitare allarmismi ma essere prudenti, ecco qualche suggerimento pratico:
-
Leggi le etichette: cerca la lista degli ingredienti; se vedi conservanti sintetici come benzoati, sorbati, nitrati, oppure sigle come “E-…”, verifica se sono necessari per quel tipo di alimento.
-
Preferisci prodotti freschi o deperibili: frutta, verdura, carne appena macellata, pesce fresco, fatto in casa, se possibile. Meno bisogno di conservanti se consumi rapidamente.
-
Attenzione ai prodotti “senza conservanti”: verificare come sono confezionati, come sono conservati; se devono stare in un frigorifero, se richiedono dispensa fresca. Un prodotto senza conservanti conservato male è peggio che qualcosa con pochi conservanti ben regolati.
-
Bilancia il tipo di alimento: un pane magari con qualche conservante è meno preoccupante di un salume ricco di nitriti o di un prodotto di pasticceria pieno di conservanti e additivi vari.
-
Riduci gradualmente il consumo di ultra-processati: questo è probabilmente uno dei modi più efficaci per diminuire esposizione a molti additivi problematici, preservanti inclusi.
-
Scegli conservanti naturali, quando possibile: sale, zucchero, acidi organici, estratti naturali che abbiano proprietà antimicrobiche/antiossidanti, ma riconoscendo che possono avere limitazioni.
In definitiva, i conservanti sono una parte integrante del sistema alimentare moderno: aiutano a garantire sicurezza, a ridurre sprechi, a mantenere qualità. Evitarli del tutto non è sempre una scelta migliore, potrebbe significare accettare prodotti meno durevoli, più costosi, o rischi igienici se le condizioni non sono ottimali.
La chiave sta nell’equilibrio: comprendere quali, in che dose, in quale tipo di alimento, e che alternative naturali possono essere adottate senza compromettere la sicurezza. E ricordare che “senza conservanti” non è automaticamente “migliore”: può essere una scelta valida, ma comporta scelte consapevoli e spesso costi aggiuntivi.