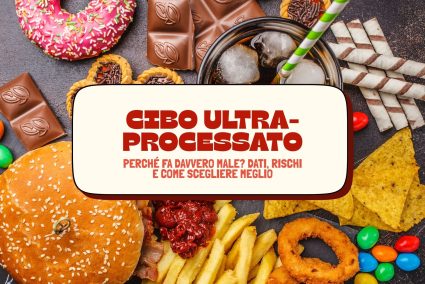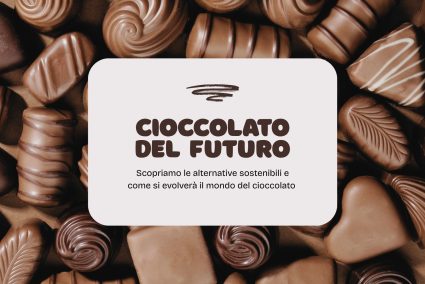Il caffè non è solo una bevanda: è un linguaggio universale. Cambiano i gesti, i profumi, le tazze, ma ovunque nel mondo quel momento di pausa racchiude qualcosa di profondamente umano. Dalla leggenda delle capre danzanti in Etiopia fino all’espresso al bancone di un bar italiano, la storia del caffè è un viaggio di aromi, culture e incontri.
Le origini: l’Etiopia e il primo risveglio del mondo
Tutto comincia, secondo la leggenda, tra le montagne dell’Etiopia, nella regione di Kaffa — da cui deriva persino la parola “caffè”. Si narra che un pastore di nome Kaldi notò le sue capre comportarsi in modo insolito dopo aver mangiato le bacche di una pianta sconosciuta. Da quella curiosità nacque un’infuso che presto conquistò i monasteri vicini, dove i monaci lo bevevano per restare svegli durante le preghiere notturne.
Dall’Etiopia il caffè attraversò il Mar Rosso e arrivò nello Yemen, dove la bevanda prese una forma più rituale. I monaci Sufi lo usavano per le loro veglie spirituali, e già nel XV secolo il porto di Mokha — da cui deriva il termine “mocha” — divenne un centro nevralgico del commercio di chicchi. Da lì il caffè iniziò il suo lungo viaggio verso il resto del mondo.
Il caffè nell’Impero Ottomano: tra tradizione e ospitalità
Nel XVI secolo la bevanda raggiunse l’Impero Ottomano e divenne presto un fenomeno sociale. A Istanbul nacquero le prime coffee houses, luoghi di incontro dove si discuteva di politica, arte e filosofia. Bere un caffè non era solo un piacere, ma un vero e proprio rito di ospitalità.
Il caffè turco, ancora oggi simbolo di accoglienza in Medio Oriente, è una delle forme più antiche di preparazione. Si ottiene macinando i chicchi finissimi e cuocendoli in un bricco di rame chiamato cezve, spesso con zucchero e spezie. La bevanda non viene filtrata, per cui i fondi restano nella tazzina — un dettaglio che in Turchia e nei Balcani ha dato origine alla curiosa usanza della “lettura del caffè”, una forma di divinazione che si fa osservando i segni lasciati sul fondo.
Nel 2013 l’UNESCO ha riconosciuto il caffè turco come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità: un segno di quanto questa tradizione sia ancora viva.
L’arrivo in Europa: da Venezia a Vienna
Il caffè sbarcò in Europa attraverso i porti veneziani nel XVI secolo. All’inizio era una bevanda esotica e costosa, venduta nelle spezierie, ma presto conquistò le corti e i ceti borghesi. Le prime botteghe del caffè di Venezia divennero luoghi di incontro eleganti e vivaci, preludio dei famosi cafè viennesi e parigini.
A Vienna, dopo la battaglia del 1683, la leggenda vuole che i chicchi abbandonati dall’esercito ottomano ispirassero la nascita della “caffetteria europea”. Lì il caffè si trasformò in un’esperienza raffinata, servito con panna e pasticcini, in ambienti dove scrittori e artisti si riunivano per discutere. Ancora oggi i coffeehouse viennesi sono un patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO, simbolo di un modo di vivere il caffè come pausa lenta, elegante e sociale.
L’Italia e l’invenzione del caffè espresso
Ma è in Italia che il caffè trova la sua forma più iconica. Venezia fu tra le prime città a importare la bevanda, ma è nel Novecento che nasce il mito dell’espresso.
Nel 1884 Angelo Moriondo, un torinese intraprendente, brevettò una macchina che usava il vapore per preparare rapidamente il caffè. Il passo decisivo arrivò qualche decennio dopo, quando Achille Gaggia introdusse il sistema a pressione: nacque così la crema superficiale, oggi marchio di qualità dell’espresso italiano.
Da quel momento, bere un caffè diventò un gesto identitario: veloce, intenso, quasi un piccolo rito quotidiano. Il bar divenne un punto d’incontro, un’estensione della piazza. E accanto all’espresso nacquero le sue varianti: il macchiato, il ristretto, il corretto, e poi il cappuccino, la colazione per eccellenza, dove l’espresso incontra il latte montato creando equilibrio tra forza e dolcezza.
La moka, inventata da Alfonso Bialetti nel 1933, portò il rito in casa. Quel borbottio inconfondibile divenne la colonna sonora dei risvegli italiani. Oggi l’80% delle famiglie italiane possiede ancora una moka: un piccolo monumento domestico al culto del caffè.
L’Africa Orientale e il rito del bunna
In Etiopia e in Eritrea, dove tutto ebbe inizio, il caffè è ancora oggi un rito collettivo chiamato bunna. Non si tratta solo di bere una tazza, ma di condividere un momento di comunità. Il rito è condotto tradizionalmente dalle donne, che tostano i chicchi verdi sul fuoco davanti agli ospiti, li pestano a mano e li fanno bollire nella jebena, una brocca di terracotta dal lungo collo.
La cerimonia si svolge in tre giri: il primo è il più forte, poi il caffè viene diluito con acqua e servito due volte ancora, a simboleggiare legame e condivisione. Spesso è accompagnato da incenso e piccoli dolci di cereali o legumi. Partecipare a un bunna significa entrare nella vita sociale di una famiglia, un segno di rispetto e appartenenza.
È un rituale lento, profondamente simbolico, che mostra come il caffè possa essere molto più di un semplice stimolante: è un mezzo per connettersi, per rallentare, per ascoltare.
Le mille forme del caffè
Ogni paese ha reinterpretato il caffè a modo suo. Negli Stati Uniti, ad esempio, il caffè “americano” — un espresso allungato con acqua calda — nacque durante la Seconda guerra mondiale, quando i soldati statunitensi cercavano di ricreare il sapore più leggero del caffè filtrato di casa.
In Australia e Nuova Zelanda nacque invece il flat white, una versione più morbida del cappuccino, con schiuma fine e consistenza vellutata.
Nei paesi arabi, il qahwa viene preparato con cardamomo e talvolta con zafferano: una bevanda dorata e profumata, servita in piccole tazze senza manico come segno di benvenuto. In Scandinavia, dove il caffè è parte della quotidianità, esiste persino una parola per descrivere la pausa caffè con i colleghi o gli amici: fika, un momento sociale tanto sacro quanto necessario.
Il filo che unisce il mondo
Ciò che colpisce nel viaggio del caffè è la sua straordinaria capacità di adattarsi a culture diversissime, restando però sempre un simbolo di incontro. In Italia è velocità e intensità, in Etiopia è lentezza e spiritualità, in Austria è eleganza e conversazione, nei paesi arabi è ospitalità.
Ogni tazza racconta qualcosa del popolo che la prepara. Eppure, che sia un espresso fumante, un caffè turco denso e speziato o un filtro profumato, il gesto di portarlo alle labbra racchiude sempre lo stesso messaggio: fermati un attimo, condividi, respira.
Perché il caffè non è solo ciò che beviamo. È ciò che succede intorno a quella tazza — le parole, gli sguardi, i silenzi. È il profumo che segna l’inizio della giornata e il sapore che accompagna le conversazioni più importanti. È, in fondo, una piccola finestra sul mondo.