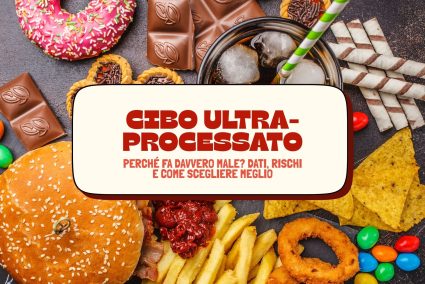L’autunno è la stagione in cui la terra rallenta, il sole si fa timido e le giornate odorano di legna e mosto. È anche il tempo in cui il confine tra il visibile e l’invisibile sembra assottigliarsi. Tra zucche intagliate, dolcetti e leggende, Halloween ci riporta a un’antica verità: il cibo non è mai stato solo nutrimento. Da sempre è rito, protezione, ricordo e magia.
Le nostre nonne lo sapevano: un piatto può portare fortuna, allontanare il male o richiamare le anime dei cari defunti. Oggi, dietro le maschere e le caramelle, si nasconde una trama di simboli che attraversa secoli e culture, tutti uniti da un unico filo: il potere simbolico del cibo.
Le origini sacre e misteriose di Halloween
Prima che diventasse la festa americana dei travestimenti e dei dolcetti, Halloween era Samhain, l’antica celebrazione celtica di fine raccolto. Si svolgeva nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, quando si credeva che il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventasse sottile come un respiro.
Il cibo era al centro di tutto: veniva offerto agli spiriti per placarli o ringraziarli, ma anche condiviso in famiglia per proteggersi. In Irlanda, per esempio, si preparava il Barmbrack, un pane dolce con uvetta e spezie che conteneva oggetti nascosti: un anello (promessa d’amore), una moneta (ricchezza), una fava (sfortuna o carestia). Una specie di lotteria rituale dal sapore profetico, che univa superstizione, divertimento e speranza.
In Scozia e in Inghilterra, invece, erano popolari le Soul Cakes, piccole torte speziate distribuite a chi bussava alle porte pregando per le anime dei defunti. “A soul for a soul cake”, dicevano: una preghiera per un dolce, un gesto semplice che univa vivi e morti in un ciclo di memoria.
Persino il gioco delle mele galleggianti — “apple bobbing” — ha origini antiche: le mele erano frutti sacri associati all’immortalità e al mondo degli spiriti. Pescare una mela con i denti significava predire l’amore o la fortuna nell’anno a venire.
E le lanterne di zucca, le famose jack-o’-lantern, nascono da una leggenda irlandese. In origine non erano zucche ma rape svuotate, usate per tenere lontano gli spiriti maligni e guidare le anime buone. Solo con l’arrivo degli immigrati irlandesi in America la rapa si trasformò nella più scenografica zucca arancione che conosciamo oggi.
In tutte queste usanze c’è lo stesso messaggio: il cibo e la tavola sono una forma di protezione. Preparare, condividere, offrire: gesti che hanno il potere di placare la paura e tenere lontano ciò che non possiamo controllare.
Le tradizioni italiane tra santi, dolci e leggende
Anche in Italia, nei giorni che circondano Halloween — Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti — il cibo assume un significato quasi sacro.
Nel Nord Italia si prepara il Pane dei Morti, un dolce scuro e morbido fatto con cacao, biscotti sbriciolati, frutta secca e vino. La sua forma allungata ricorda quella del pane condiviso durante i banchetti funebri dell’antica Roma. È un cibo-memoria, che si offre per “nutrire” simbolicamente le anime dei defunti.
Nel Centro e nel Sud troviamo le Fave dei Morti, biscotti alle mandorle che riprendono una tradizione antichissima: per i Romani, la fava era legata al mondo dei morti perché il suo interno bianco richiamava le ossa e perché, secondo le credenze, conteneva l’anima dei defunti. Ancora oggi, in alcune regioni, si dice che mangiarle aiuti a “fare pace” con i propri antenati.
In Sardegna si preparano i Pabassinas, dolci con noci e uvetta il cui nome deriva da “pabassa”, cioè uva passa. In Sicilia i bambini ricevono dolci e regali “dai morti” durante la notte tra l’1 e il 2 novembre, un modo per insegnare che la morte non è assenza, ma continuità d’affetto.
Ecco allora che la nostra cucina, come quella celtica, usa il cibo per ricordare, onorare, proteggere. Ogni morso racconta una storia di passaggio e rinascita.
Piatti magici dal mondo
Ma non è solo l’Europa a fondere cibo e mistero. In molte culture, le cucine si popolano di superstizioni e riti culinari.
Nelle Filippine, durante “l’Atang”, si prepara un’offerta di riso, dolci e tabacco per gli spiriti dei defunti. È un gesto di rispetto ma anche un modo per mantenere l’equilibrio tra il mondo visibile e quello invisibile.
In Portogallo, nel giorno di Ognissanti, i bambini bussano alle porte chiedendo il Pão-por-Deus (“pane per Dio”), ricevendo dolci o pane in segno di benedizione. È una tradizione che ha anticipato il moderno “trick or treat”, ma con una dimensione spirituale più profonda.
In Grecia, durante la commemorazione dei defunti, si prepara la kollyva, un piatto di grano bollito con zucchero, noci e melograno: simbolo di rinascita e vita eterna, offerto alle anime dei morti.
E poi ci sono le zuppe apotropaiche, cioè “che scacciano il male”: in alcune regioni dell’Europa dell’Est, la notte di Ognissanti si cucinava una zuppa d’aglio, credendo che il suo profumo tenesse lontani gli spiriti maligni e proteggesse la casa. Un’usanza sopravvissuta, in forme diverse, fino al moderno “brodo dell’anima” che ancora oggi molti preparano nelle giornate fredde e nebbiose.
Il cibo come protezione
Ogni cultura ha un piatto che protegge, una ricetta che purifica, un dolce che porta fortuna.
E anche se oggi ne ridiamo o li chiamiamo “riti folcloristici”, questi gesti nascono da un bisogno antico e universale: dare un senso al mistero.
Una lanterna accesa, una mela lasciata sul davanzale, una fava sgranata in silenzio: tutto parla di gratitudine e paura, di memoria e speranza.
A tavola, in fondo, siamo sempre in bilico tra superstizione e fede, tra il quotidiano e l’invisibile.
E forse è proprio questo che rende Halloween — e tutte le feste simili — così irresistibili: la possibilità di guardare il buio, ma con una candela accesa e un dolce tra le mani.